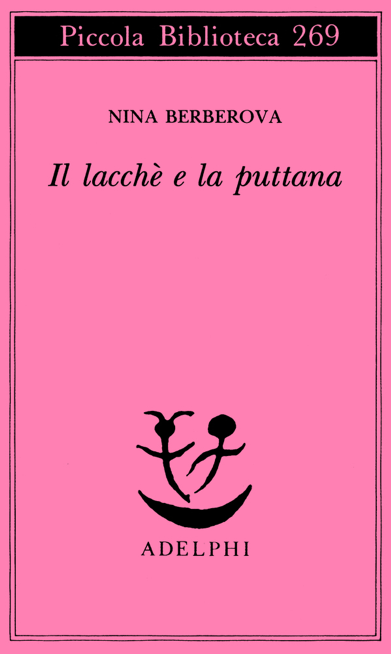 La scrittrice russa Nina Berberova pubblicò il libro “Il lacchè e la puttana” nel 1937. Si tratta di un racconto lungo che si legge tanto velocemente quanto rapidamente rilascia nel lettore un veleno che poi impiegherà molto più tempo a produrre i suoi effetti.
La scrittrice russa Nina Berberova pubblicò il libro “Il lacchè e la puttana” nel 1937. Si tratta di un racconto lungo che si legge tanto velocemente quanto rapidamente rilascia nel lettore un veleno che poi impiegherà molto più tempo a produrre i suoi effetti.
Il realismo della prosa della Berberova è asciutto ma perfettamente aderente alla miseria della storia rappresentata, essenziale quanto disperata. La storia è quella di Tanja, la “puttana”, esule al pari dell'autice da una Russia che è lontana e ostile, ma che resta un pensiero fisso in una Parigi del tutto trascurabile, che funge da sfondo monotono e squallido di vicende poco edificanti.
La patria lontana è stata la culla di una giovinezza spensierata, ma l'esilio rappresenta la strada di un presente esausto che non regala speranze, sogni o progetti. Tanja è sola, senza lavoro e lontana dalla tranquillità economica, situazione che le incattivisce l'animo e la spinge alla ricerca di un uomo che possa consegnarla ad un minimo di sicurezza. Il destino le riserverà un cameriere in là con gli anni che riversa tutte le attenzioni di cui è capace su di lei. Ma l'incomunicabilità indissipabile fra donne e uomini scava un solco fra i due che il pessimismo dell'autrice non permette di colmare.
Tanja viene alla luce, in maniera volutamente sintetica, come una donna che è in cerca di un senso alla propria vita, ma è un senso minore, privo di slanci e di ideali (“Non sapeva cosa fosse la vita, ma sentiva che non era quello, non poteva essere quello”).
Il libro delinea un contesto e una realtà che turbano per le assenze, per i vuoti, per le atmosfere asfissianti. La narrazione si dipana come un tessuto povero che induce ad una riflessione su come sia possibile ritrovarsi in tali condizioni di abiezione e di mortificazione (“Ma, grazie a Dio, non c’era futuro”).
L'esilio divora qualsiasi normalità che la patria concedeva, vieta ogni serenità e preclude anche una felicità minima. Per cui la Russia resta sullo sfondo come un Eden irrangiungibile che violenta psicologicamente tutti coloro che ne siano stati cacciati, lavorando come un tarlo tanto nella memoria collettiva quanto in quella individuale, fino a dilatare i sensi di colpa di chi trasfigura l'esilio coatto in abbandono volontario e infamante.
Le condizioni soggettive dei personaggi turbano il lettore (“la paura della fine, forse della vecchiaia, e il presente stava davanti a lui come un enorme peso che non riusciva a smuovere”), ma l'autrice rifugge ogni valutazione morale e si vieta qualsiasi manifestazione di giudizio nei confronti di soggetti pronti a tutto e buoni a niente, ai quali guarda con la tristezza e la condiscendenza di chi conosce quanto il mondo sia difficile da interpretare e ancor più ostico da assecondare alla ricerca di quel minimo di serenità cui tutti avrebbero diritto.

Commenta
Commenti