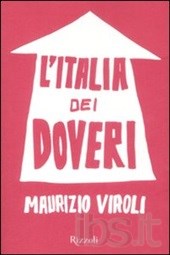 “L’Italia dei doveri” di Maurizio Viroli, professore di Teoria politica all’università di Princeton, nasce da un’idea di Norberto Bobbio: “Se avessi ancora qualche anno di vita, che non avrò, sarei tentato di scrivere l’Età dei doveri”.
“L’Italia dei doveri” di Maurizio Viroli, professore di Teoria politica all’università di Princeton, nasce da un’idea di Norberto Bobbio: “Se avessi ancora qualche anno di vita, che non avrò, sarei tentato di scrivere l’Età dei doveri”.
Senza doveri non c’è libertà: è questa la tesi dell’interessante saggio. Purtroppo è opinione comune che la vita sia godimento dei diritti al punto che appare quasi stravagante il pensiero che dietro i diritti si celino anche dei doveri. Con una prosa limpida Viroli ci accompagna, attraverso efficaci esempi tratti dalla storia e dalla cronaca, alla riscoperta del dovere, un valore spesso disatteso, quando non completamente dimenticato.
“L’indifferenza morale di tanti italiani è talmente miserabile o squallida, a seconda dei casi, da non meritare comprensione e ancor meno perdono. Gli indifferenti non solo offendono il senso morale, ma fanno paura”.
La nostra Costituzione (che secondo il professore, più che essere modificata, deve essere riscoperta per farla diventare la bussola morale del popolo) presenta, insieme ai diritti, un coerente sistema di doveri. Una classe politica preparata e con un’adeguata consapevolezza dei doveri civici potrebbe governare opportunamente con la Costituzione. Attaccare la Carta costituzionale equivale a nascondere la propria inidoneità a rappresentare il popolo.
Dalla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” (1791), alla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (1948) e fino alle più attuali dichiarazioni degli Stati, i diritti sono stati estesi a un numero sempre più ampio di uomini, diventando al contempo anche più specifici, ovvero indirizzati a gruppi sempre più particolari: i diritti dei bambini, delle donne, dei disabili. Tuttavia i diritti senza doveri diventano vuoti e si allontanano dalla libertà che devono invece tutelare. C’è necessità del senso del dovere, “ovvero del rispetto delle regole e dei principi morali non per interesse o per timore della legge, ma semplicemente per l’obbligo che si ha nei confronti della propria coscienza”.
“Senza medici e personale sanitario con senso del dovere, il diritto alla salute diventa una crudele finzione; senza maestri, insegnanti e professori con il senso del dovere, il diritto all’educazione e alla cultura diventa una crudele finzione”.
Un insegnante che si rispetti, oltre all’erudizione, deve comunicare il potere della cultura, il rispetto delle regole e una coscienza morale. Deve formare cittadini consapevoli, pur nella complessità e molteplicità delle vicende umane. Deve aprire ai giovani gli orizzonti dei sommi problemi, dare il senso della serietà e della drammaticità della vita. Solo così da insegnante potrà essere anche un maestro.
Discende dal dispregio dei doveri la corruzione, che si diffonde rapida come un tumore. Nell’ultima rilevazione di Transparency International, l’associazione che si occupa di misurare la corruzione nel mondo, l’Italia (fanalino di coda per la trasparenza in Europa) appare, in una classifica mondiale, al 72° posto su 174 con un punteggio di 42 su 100.
“Ci sarebbe da vergognarsi di essere italiani, ma la vergogna, quella seria, è la sofferenza che nasce non dal timore del giudizio degli altri ma dal rimorso per aver violato il comando della coscienza, vale a dire il senso del dovere”.
Purtroppo la mentalità italiana si basa sul disprezzo del debole e sulla devozione “del capo onnipotente che calpesta limiti e leggi o li piega a proprio vantaggio”. Invece di denigrare il soverchiatore, l’italiano sogna di prenderne il posto.
Lo aveva perfettamente capito, già nel 1928, Carlo Rosselli, quando scrisse: “triste cosa a dirsi, ma non per questo meno vera, che in Italia l’educazione dell’uomo, la formazione della cellula morale base –l’individuo- è ancora in gran parte da fare. Difetta nei più, per miseria, indifferenza, secolare rinuncia, il senso geloso e profondo dell’autonomia e della responsabilità. Un servaggio di secoli fa sì che l’italiano medio oscilli oggi ancora tra l’abito servile e la rivolta anarchica. Il concetto della vita come lotta e missione, la nozione della libertà come dovere morale, la consapevolezza dei limiti propri e altrui, difettano”.
Dobbiamo insegnare ai più giovani il dovere dello sdegno, ovvero il senso di repulsione per l’ingiustizia che è degli animi grandi e sconosciuto agli animi vili e meschini. Spero sempre che tra i più giovani si celi un futuro Giacomo Metteotti, un futuro Gaetano Salvemini, un futuro Giorgio Ambrosoli. E spero sempre che anche in noi possa conservarsi vigoroso lo “sdegno che accende”, come disse Bobbio nel 1943, come “arma senza la quale non vi è lotta che duri ostinata, senza la quale, vittoriosi, ci si infiacchisce, e, vinti, si cede”. Il nostro tempo reo ne ha davvero bisogno.

Commenta
Commenti