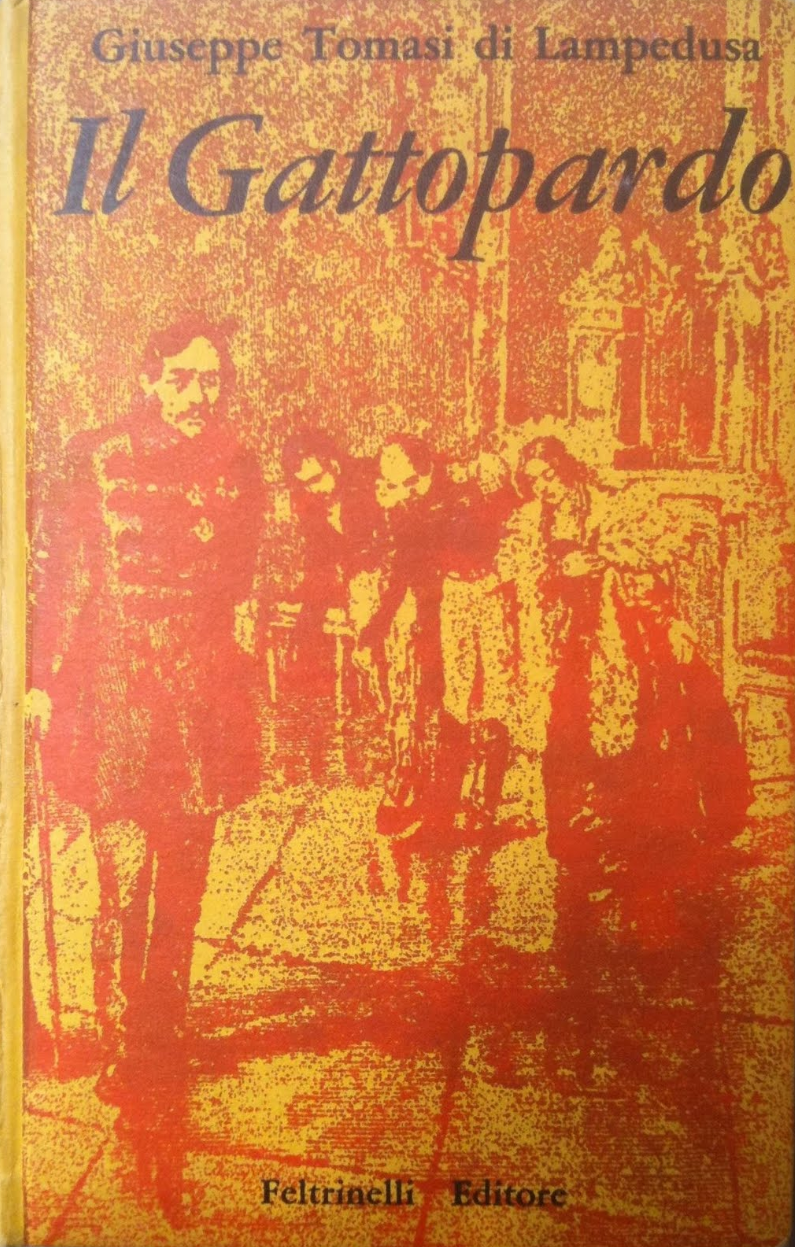 Lessi “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa la prima volta a quattordici anni per obbligo scolastico e non mi innamorai del giovane Tancredi, ma del principe don Fabrizio Salina, possente e forte, infatti “le sue dita sapevano accartocciare come carta velina le monete da un ducato”.
Lessi “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa la prima volta a quattordici anni per obbligo scolastico e non mi innamorai del giovane Tancredi, ma del principe don Fabrizio Salina, possente e forte, infatti “le sue dita sapevano accartocciare come carta velina le monete da un ducato”.
Da allora ho un debole per la Sicilia, ne annuso l’odore dei limoni e sogno esplorazioni nelle vecchie dimore nobiliari, il cui fascino grandioso resiste al tempo.
“Il Gattopardo” è un romanzo storico sulla società siciliana (in particolare sull’aristocrazia) descritta dal 1860 fino alla fine del secolo. Il protagonista è proprio don Fabrizio, astronomo assai noto e premiato alla Sorbona; in principio resta indifferente all’arrivo dei garibaldini, poi vi aderisce e per convenienza e per gli entusiasmi del caro nipote Tancredi, principe di Falconieri.
Tancredi ha intuito l’opportunità di combattere fra i garibaldini; sarà rispettivamente ufficiale, deputato e diplomatico del nuovo Regno. Sposerà, sollecitato dallo zio, Angelica Sedàra, donna molto affascinante e figlia di un parvenu che diventerà senatore. Calogero Sedàra diventa simbolo della sfrontatezza della ricchezza accumulata rapidamente e in modo poco chiaro.
Felice dal punto di vista narrativo è il capitolo sul ballo (riprodotto magnificamente da Luchino Visconti nella versione cinematografica), dove gli aristocratici palermitani si rallegrano, due anni dopo lo sbarco, contenti “che nulla sia cambiato”.
Pagina dopo pagina il lettore impara a conoscere meglio il principe Fabrizio, tenacemente legato alla propria terra e lucidamente ancorato alle proprie disillusioni, fino alla morte avvenuta nel 1883. “In Sicilia non importa far male o far bene; il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare”.
La trama si svolge in un tessuto di episodi nei quali i soggetti vengono tratteggiati con una semplice pennellata o riassunti integralmente nella concisione di una frase; l’autore indugia in discussioni sulla persistente utilità del ceto nobiliare, sulla ininfluenza del susseguirsi al potere delle varie classi sociali, sul significato dell’esistenza, in una rassegnata e persistente idea della morte: “Finchè c’è morte, c’è speranza”. Tante cose appaiono vacue e acquisiscono anch’esse sapore di morte: la volgarità della borghesia; l’orgoglio nobiliare; il fascino, il potere tout court. Tuttavia la vita sorprende con moti imprevedibili.
Così la storia riempie il proprio tempo, ma contemporaneamente fugge via: attraversa l’anima dei personaggi, i palazzi sbrecciati, i giardini rigogliosi. E, attraversato lo Stretto, arriva fino a noi, tentando di destarci: "Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra".

Commenta
Commenti